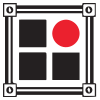In 12 anni ci sono stati, nel mondo, 500 sequestri (vedi Journal of Security n. 0) di materiale potenzialmente utilizzabile per armi di distruzione di massa (nella foto sopra: test su un campione di uranio). Chi sono i protagonisti di questo commercio? “In realtà sappiamo ancora poco e non ci sono prove che questo materiale servisse a organizzazioni terroristiche. Abbiamo il profilo solo dei venditori e non degli acquirenti. Il mondo è cambiato, da questo punto di vista. Durante la guerra fredda, il problema era la proliferazione delle adm e che ci fossero scambi fra Stato e Stato. Adesso invece l'attenzione è concentrata sui non-state actors, gruppi illegittimi, ma che hanno capacità organizzativa e soldi per gestire il traffico. Sto parlando di criminalità organizzata e terrorismo. Finora, nei vari casi in cui il traffico illecito è stato scoperto, ci siamo trovati di fronte a singoli individui, spesso legati ai luoghi di produzione del materiale”.
Gli Stati sono pronti ad affrontare questo fenomeno? “Dagli anni '90, lo sforzo di un singolo stato non è più sufficiente per un'efficace prevenzione. E' importante che gli Stati collaborino fra loro, non solo scambiandosi informazioni d'intelligence, ma armonizzando le procedure di controllo. E' come per le frodi fiscali: se uno Stato non adotta una certa legge, rende vani gli sforzi degli Stati vicini”.
Quindi occorre costruire aree di sicurezza comuni? “Sì. Ci vogliono sforzi collettivi all'interno di una regione per limitare gli spazi di manovra del traffico. In particolare, bisogna avere un schema comune che permetta di scambiare informazioni omogenee e comprensibili a tutti. E poi ci vogliono network di persone che coinvolgano polizia, dogane, autorità (anche civili) che controllano i siti di produzione, medici per affrontare le emergenze… E' un aspetto fondamentale”.
Voi vi occupate di trovare strategie per fermare i traffici illeciti. Vi ponete il problema degli effetti che queste strategie possono avere sul commercio internazionale? “E' difficile trovare un equilibrio fra il controllo del maggior numero di container e la fluidità dei traffici legali. In effetti, non è una questione che spetta all'Unicri affrontare, quanto piuttosto ai vettori, come per esempio gli armatori”.
Non pensa che esista il rischio che la paura ci condizioni in maniera eccessiva? “Come cittadino, posso dire che il terrorismo sta condizionando le nostre vite. Le faccio un esempio. Quando è avvenuto l'attacco a Londra, io ero al sicuro a Bucarest, eppure la mia famiglia, a causa della lontananza, si è ugualmente preoccupata di sapere che io stessi bene. E' una reazione naturale alzare la soglia di attenzione. La ricerca deve saper andare nella direzione di un maggiore controllo, senza che questo abbia un impatto sul flusso delle merci. Ma poi dipende anche da chi finanzia la ricerca: noi operiamo in stretto contatto con i diversi Paesi, cercando di ottenere risultati che abbiano validità operativa. Le nostre linee guida sono dettate dalle preoccupazioni e dalle necessità dei governi”.